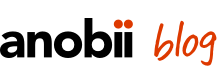C’è vita dopo il premio? Arrivare a un riconoscimento per il proprio lavoro di scrittore prima dei quarant’anni come cambia il lavoro di scrittore? E, già che ci siamo, che lavoro è fare lo scrittore?
Per una felice combinazione il bar dove vado a fare colazione e lavorare con il mio computer è anche quello dove spesso viene Paolo Cognetti, da pochissimi giorni diventato quarantaduenne, scrittore milanese amante degli Usa e della montagna. E vincitore del Premio Strega 2017.
Paolo ha scritto sia saggi (soprattutto su New York) che romanzi, incluso “Le otto montagne” con cui ha vinto lo Strega, il Prix Mèdicis ètranger e l’English Pen Translates Award. Ma non è nuovo ai riconoscimenti, che nella sua carriera sono stati numerosi sin dal suo esordio letterario nel 2003 con il racconto “Fare ordine” (contenuto nell’antologia La qualità dell’aria). Ma andiamo con ordine.

Paolo, cominciamo con il premio finora più importante, lo Strega. Anzi, con quello che succede dopo: cosa cambia dopo aver vinto il Premio Strega nella vita di un autore?
La cosa più bella è che il mondo ti riconosce finalmente come scrittore. Sai, prima per tanti anni (io ho cominciato verso i 18) quando le persone ti chiedono “tu cosa fai?”, oppure “cosa vorresti fare?”, rispondi “lo scrittore!” e ricevi in cambio un misto di ilarità e diffidenza, come dire l’astronauta o la ballerina. “Sì, ma di lavoro cosa fai?”, è la domanda successiva. In effetti, per tanto tempo di lavoro ho fatto il documentarista, il montatore video, l’insegnante di scrittura, il barista e pure il cuoco in un ristorante di montagna. Tutte cose che ho fatto volentieri, ma dentro di me erano solo espedienti, mestieri necessari per campare, io volevo fare lo scrittore. La fede qualche volta ha vacillato: ho pubblicato diversi libri senza mai riuscire a viverci davvero, e mentre a vent’anni la cosa non ti sembra un problema (anzi è molto romantico fare lo scrittore squattrinato), verso i quaranta ti accorgi di essere ancora senza un soldo e cominci a chiederti: ma è proprio questa la vita che volevo fare? Non è che ho sbagliato sogno? E se fosse stata solo una grande fregatura? Poi le cose sono cambiate di colpo. Ora parlo, mi vesto e mi presento assolutamente come prima, ma se uno sorride o alza il sopracciglio posso dirgli: “Sì, faccio lo scrittore: ho scritto un libro che ha vinto il premio Strega, è stato tradotto pure in arabo e in cinese e ha venduto un milioncino di copie nel mondo. Problemi?” È una bella soddisfazione. Ci sono anche aspetti negativi, ma dopo una fortuna così sfacciata non mi sembrerebbe giusto parlarne.
Accanto alla scrittura c’è anche il video: ti sei diplomato alla Civica scuola di cinema di Milano, e ti occupi di realizzare documentari politici, sociali e letterari. Mi racconti quel lato della tua vita?
È un lavoro che mi è piaciuto molto e che vorrei continuare a fare, qualche volta. Mi ero iscritto alla scuola di cinema perché la Civica a Milano è un’istituzione, e pensavo che, studiando lì, avrei perlomeno imparato a raccontare storie. Poi è successo che nei due anni di scuola mi sono innamorato del documentario, un modo meraviglioso per viaggiare e conoscere le vite degli altri. Se la scrittura di un romanzo è claustrofobica, perché sei tu lì da solo con i tuoi ricordi e le tue fantasie e i tuoi amici immaginari, il documentario invece è apertura, curiosità, esplorazione del mondo. L’ultimo l’ho girato in Canada e Alaska nel 2019, si intitola “Sogni di grande Nord” ed è una ricerca di quella frontiera mitica per la letteratura americana, sulle tracce dei miei amati Thoreau, London, Hemingway e Carver.
Hai scritto libri e girato documentari sulla letteratura americana: perché? Cosa significa per te l’America?
È la letteratura su cui mi sono formato. Non ho fatto l’università per insofferenza verso l’istituzione, ma in compenso ho studiato da solo (come Leopardi! “Studi matti e disperatissimi”) la letteratura verso cui mi sentivo più attratto, cercando di imparare a scrivere. Degli scrittori americani ho amato tanto la libertà, il senso di anticonformismo e di rivolta. Per Pavese erano “i barbari”, lo diceva con ammirazione: venendo dagli studi classici, con tutto il peso della nostra tradizione sulle spalle, quegli scrittori incolti e avventurosi gli sembravano più vitali, liberi e autentici di lui. L’ho pensato per tanto tempo anch’io. Sono affezionato a Carver, a Bukowski, a Fante, alla Beat Generation di Ginsberg e Kerouac, e poi a Hemingway, Fitzgerald, Salinger, Capote e compagnia. Solo che dopo un po’, soprattutto per via del rapporto con la lingua, ho sentito il bisogno di tornare agli scrittori italiani. Li ho scoperti dopo i trent’anni. In Rigoni Stern, in Fenoglio, nella Ginzburg, posso assaporare una lingua e abitare dei luoghi che sento vicini ai miei, questo prima non aveva importanza, adesso sì. Se prima la lettura era un desiderio di viaggiare lontano, adesso è qualcosa di più simile a un ritorno a casa. Come si cambia, nella nostra vita di lettori…
Sei anche un moderno eremita: ami la montagna e passi ogni anno alcuni mesi da solo in alto, lontano dal resto del mondo. Cosa cerchi?
Be’, come sai passo del tempo anche nei bar di Milano! La città e la montagna sono le mie due metà, che non sento in conflitto tra loro. La montagna risponde al desiderio di grandi spazi, di libertà del corpo, di vicinanza ai boschi, ai torrenti, agli animali selvatici. Passo circa sei mesi l’anno in Valle d’Aosta, in una baita a 1900 metri d’altezza, e lì la mia vita diventa una cosa molto semplice fatta di scrivere, camminare, spaccare la legna, guardare scorrere le stagioni, stare con i miei amici montanari. La città invece è l’incontro con la varietà umana, è lo spettacolo della diversità, e più una città è grande e aperta più mi piace. Sono molto affezionato a New York, ci ho passato tanto tempo – non per i grattacieli, ma perché nelle sue periferie si parlano 180 lingue diverse. Anche la Milano di questi anni mi piace. Ci sono nato e ho sempre avuto un rapporto conflittuale con lei, a volte mi è sembrata così brutta e triste da voler scappare via, oggi la apprezzo di più. Abito a Chinatown, amo ancora stare in mezzo a gente che parla una lingua diversa dalla mia.

Nel 2009, a poco più di trent’anni, hai vinto il premio della rivista Lo Straniero di Goffredo Fofi. Quanto sono importanti i riconoscimenti per cominciare il proprio viaggio nella scrittura?
Quello dello Straniero è stato un premio importantissimo per me. Goffredo è un intellettuale che si è sempre sporcato le mani, uno che ha dedicato la vita all’azione sociale senza aver mai fatto distinzione tra letteratura, cinema, teatro, educazione, integrazione, attratto da ogni tipo di periferia e minoranza. Per me è un maestro d’anarchia (una parola molto bella e maltrattata). Il fatto che a trent’anni, dopo un paio di libri si sia accorto di me, definendomi “uno scrittore vero”, mi ha riempito di coraggio per proseguire. Certe volte ce n’è voluto molto.
Un’ultima cosa: viaggiare vuol dire camminare, o sono possibili anche altri mezzi e altre velocità?
Viaggiare vuol dire far fatica, affrontare imprevisti, aprirsi agli incontri inaspettati, deviare dal percorso stabilito, ammalarsi di qualche strano virus, sentirsi lontani da casa, mettersi nei guai e cavarsela da soli. Un’esperienza sempre più rara: oggi con un telefono e una carta di credito sei al sicuro ovunque, e il viaggiatore non è che un cliente di questo mercato che è il turismo globale. Credo che il viaggio, in futuro, sarà sempre più il tentativo di sottrarsene: sfuggire al mercato, uscire dalla rete. Allora anche la distanza conta poco, casomai contano il tempo, la concentrazione, la fatica del camminare. Lo insegnava Thoreau: un anno passato nel bosco dietro casa può rivelarsi un viaggio più autentico e avventuroso che una settimana in capo al mondo.
Grazie Paolo!